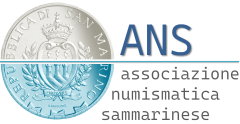Le conferenze di San Marino Numismatica 2025: storia, falsificazione e identità monetaria
San Marino Numismatica 2025 ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento non solo per il mercato e il collezionismo, ma anche per l’approfondimento culturale e scientifico, grazie a un articolato ciclo di conferenze dedicato al tema del falso monetario, curato dall’ANIT – Accademia Italiana di Numismatica e moderato da Raffaele Iula.
Ad aprire i lavori è stato proprio Raffaele Iula con l’intervento “Per un’introduzione al fenomeno delle imitazioni e delle contraffazioni monetarie: il caso del Mezzogiorno medievale (XI–XIII secolo)”.
Il relatore ha offerto una solida cornice teorica al tema delle monete false in epoca medievale, un ambito che negli ultimi anni ha suscitato crescente interesse per i numerosi spunti di ricerca che offre, sia dal punto di vista tecnico-numismatico sia sotto il profilo giuridico. Particolare attenzione è stata riservata alla distinzione tra falso e imitazione monetaria, concetti spesso sovrapposti ma profondamente diversi: mentre le imitazioni potevano rientrare tra le emissioni ufficiali di entità statali riconosciute, i falsi rappresentavano una minaccia economica e politica, lesiva del prestigio dell’autorità emittente e perseguita con pene severe.

Amalfi. Tarì aureo «de lu grillu», XI secolo (0,90 g. – 18 mm). Collezione privata.
Il Mezzogiorno medievale si è rivelato un osservatorio privilegiato per analizzare tali fenomeni, poiché le imitazioni costituivano una manifestazione diffusa della cultura materiale ed economica dell’epoca. L’analisi si è sviluppata attraverso esempi concreti, dalle imitazioni dei tarì arabi delle zecche di Amalfi e Salerno e le loro evoluzioni, fino ai falsi di età sveva, toccando anche il caso emblematico dell’accusa di “re falsario” rivolta dalla propaganda pontificia a Federico II di Svevia (1198–1250), figura storica di straordinario carisma.
Su questa base metodologica si è inserito l’intervento di Davide Fabrizi, dedicato a Pietro Giovanni Paolo Cantelmo, duca di Sora e di Alvito, personaggio centrale delle congiure baronali di fine Quattrocento. Alla luce di recenti scoperte documentarie, Fabrizi ha approfondito l’attività di Cantelmo come falsario, soffermandosi sulla coniazione non autorizzata del bolognino, tradizionalmente attribuita alla prima congiura dei baroni, ma oggi oggetto di una nuova e più problematica datazione.

Pietro Giovanni Paolo Cantelmo (†1497). Bolognino di 1° tipo (18 mm – 0.70 g.). Collezione privata.
Il tema della falsificazione in età moderna è stato poi affrontato da Mario Limido, che ha ricostruito la vicenda della Rocca di Briona, nei pressi di Novara, trasformata all’inizio del XVII secolo in una vera e propria zecca clandestina. Protagonista della storia fu Giovanni Battista Caccia, detto il Caccetta, che approfittò del caos monetario del periodo per produrre monete false destinate alla circolazione nel Piemonte e nel Ducato di Milano. Un’attività che, più che dal semplice lucro, sembrò motivata dalla necessità di finanziare la sua opposizione al dominio spagnolo, in una vicenda che la tradizione ha persino collegato all’ispirazione manzoniana dei Promessi sposi.

Milano. Filippo III d’Asburgo (1598-1621). Ducatone in argento (31,48 g.; 40 mm.). Ex NAC 44, lotto n. 697. Per gentile concessione di Numismatica Ars Classica NAC AG.
Con l’intervento di Alberto D’Andrea e Umberto Moruzzi, l’attenzione si è spostata su Agostino Rivarola e sulla falsificazione monetaria a Venezia. Attraverso un ampio excursus storico-numismatico, i relatori hanno analizzato i provvedimenti adottati dalla Serenissima fin dal XIII secolo contro falsari, tosatori e fiancheggiatori, fino ad arrivare al caso del Rivarola, attivo tra Parma, Massa, Mirandola, Correggio e Tresana. Grazie a una rete di appoggi, egli riuscì a imitare monete straniere molto richieste nei traffici internazionali, ma la plateale falsificazione di monete veneziane e austriache gli costò la condanna a morte in contumacia da parte della Repubblica di Venezia nel 1623 e l’intervento del tribunale di Vienna pochi anni dopo.

Lowenthaler battuto dal Rivarola a Correggio (1620-1626 circa).
A concludere il ciclo di conferenze è stato Roberto Ganganelli con l’intervento “Aurea Libertas. Cento anni di monete d’oro a San Marino”. Partendo dai depositi del MFM – Museo del Francobollo e della Moneta, dai documenti dell’Archivio di Stato e dalla bibliografia esistente, la relazione ha ricostruito la complessa genesi delle 10 e 20 lire d’oro del 1925, prime monete auree della Repubblica di San Marino, svelando corrispondenze inedite con la Regia Zecca, modelli originali di Melchiorre Fucci e dettagli finora poco conosciuti.

Modelli in gesso della 20 lire d’oro del 1925
(Foto concessa dall’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino).
Un ciclo di incontri che ha dimostrato come San Marino Numismatica sia non solo una manifestazione espositiva, ma anche un luogo di studio, confronto e alta divulgazione, capace di unire rigore scientifico e passione per la storia della moneta.